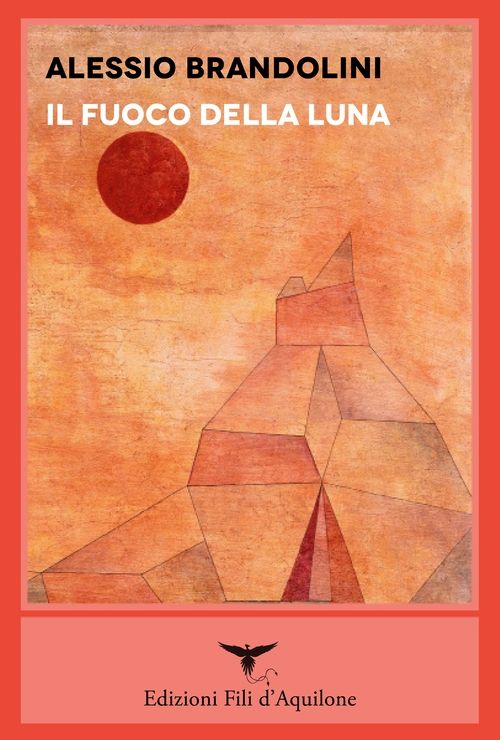 Giunto al suo decimo libro di poesie, Alessio Brandolini, anche traduttore e direttore di Fili d’aquilone, lo pubblica presso la casa editrice da lui fondata nel 2011, le Edizioni Fili d’Aquilone. Giunto al suo decimo libro di poesie, Alessio Brandolini, anche traduttore e direttore di Fili d’aquilone, lo pubblica presso la casa editrice da lui fondata nel 2011, le Edizioni Fili d’Aquilone.
Una tensione forte allinea, come su una corda d’acciaio ben tirata, le 68 fra poesie e prose poetiche che costituiscono il compatto volume dal titolo Il fuoco della luna, compatto pur se diviso in quattro sezioni. Ad alimentare tale tensione il lacerante contrasto fra desiderio e realtà, dolore e noia, passato e presente, memoria e indifferenza, fuga e ritorno, rabbia e resilienza, panico e quiete, solitudine e comunione, sbagli e insegnamenti, e tutto ciò tutto insieme, in un vortice tumultuoso e umanamente contraddittorio. Fin dal titolo della raccolta, dove della luna, così cara ai poeti, e per loro di volta in volta lontana, fredda, luminosa, indifferente, sacra, pallida, con efficacissimo ossimoro Brandolini evoca il calore, il fuoco della luna, appunto, o, come dice nella poesia Sulla soglia del sonno (p. 13), “Lassù una luna in fiamme che scalda”.
Mi si consenta di raccontare un giochino che ho fatto, lanciando su un motore di ricerca le parole “Alessio Brandolini”. Naturalmente, sono uscite molte occorrenze relative al nostro poeta. Ma, poiché internet persegue finalità prevalentemente commerciali, le prime, e numerose occorrenze, riguardavano un omonimo vignaiolo dell’Oltrepò pavese, la cui famiglia si dedica alla viticoltura dal 1873, sempre sugli stessi terreni, vantando sul proprio sito: “Da generazioni coltiviamo l’amore per la nostra terra”. Ho, allora, pensato che fosse una simpatica coincidenza; mi ha divertito pensare che in quel nome e cognome ci sia un destino di attaccamento alla terra natìa e ai suoi valori, all’eredità che si riceve dagli avi e che si lascia ai figli, un’eredità fatta di cultura del lavoro, che alimenta la dignità dell’uomo e innerva l’etica familiare, legando in una sola ininterrotta catena i vecchi e i giovani, i morti – prepotentemente presenti – e i nuovi nati, il passato e il futuro.
La terra
La terra, fonte permanente di ispirazione (già la raccolta poetica pubblicata nel 2004 s’intitola, semplicemente ma potentemente, Poesie della terra), non è solo ambientazione autobiografica, nel richiamo alla natìa Monte Compatri, alla casa di via degli Artisti (dalla toponomastica profetica), alla vigna, agli olivi, alle cantine del paese, ai lecci su cui, novello “barone rampante”, Alessio bambino si arrampicava, passando da un albero all’altro di ramo in ramo (Il bambino senz’ali, p. 10). Non c’è oleografia ma attenzione affettuosa verso la realtà domestica minuta e quotidiana, nella quale si svelano verità universali, una disposizione d’animo prossima, per certi aspetti, al sentimento di Emily Dickinson. Che cito non a caso, dal momento che la poetessa americana figura con ben tre titoli nelle collane I Fili e Fili d’oro, pubblicate dalla casa editrice di Brandolini, e che, sulla stessa rivista web diretta dal poeta, c’è una rubrica fissa, “L’angolo di ED”, dedicata appunto alla Dickinson, curata da Giuseppe Ierolli, traduttore delle tre antologie succitate.
Insomma, la mia sensazione è che in Brandolini ci sia una religione non morbosa e non astratta della natura. Nessun idillio, semmai un’etica quasi esiodea, basata sulla fatica, sul sudore e su pratiche concrete. In Il bambino senz’ali (p. 10) dice il poeta: “Lavoravo sodo per un abbraccio. Nulla / di più, aiutare la famiglia”; in Le tue mani sono alberi (p. 14), il reincontro desiderato col padre, a due anni dalla scomparsa, non è sogno evanescente ma accade davvero, “qui dove ho / costruito una casa e insieme abbiamo piantato ulivi / la piccola vigna, il ciliegio, i due noci e il castagno”. La trama degli affetti non è immateriale nostalgia ma ricordo di opere progettate e realizzate insieme e che, perdurando nel tempo, testimoniano oggi la continuità dei legami. Quel ricordo è ancora qui, nei rami contorti degli ulivi, nella fioritura leggiadra del ciliegio, nella generosità autunnale del noce e del castagno.
Ma non c’è nulla di arcadico o idealizzato, anzi, ancora una volta, la campagna è faticosa ed esigente e occuparsene rientra talvolta nella routine che ci distrae dall’essenziale. In Tutto sembrava così facile (p. 45) si dice: “[…] di corsa perché ho sempre troppe / cose da fare: spedire libri, pagare tasse, piantare / altri ulivi perché il gelo ne ha uccisi parecchi”. Non è hobby del giardinaggio nella casetta del weekend; la cura della terra non è passatempo ma insopprimibile necessità; si fa perché non è pensabile non farlo, è un habitus acquisito da sempre.
Apro un’altra piccola parentesi a proposito di una singolare coincidenza temporale, che ha a che vedere con l’intertestualità che attiene al lettore. Leggere è anche tracciare linee fra i libri e gli autori per cogliere analogie e differenze. Così, negli stessi giorni in cui sto rileggendo questi versi, una contemporanea lettura che sto conducendo mi ha fatto imbattere in un personaggio letterario antitetico all’io narrante delle poesie di Brandolini. Si tratta del protagonista del ponderoso romanzo, intitolato I libri di Jakub, del Premio Nobel 2018 per la Letteratura Olga Tokarczuk (Milano, Bompiani, 2023), la cui filosofia di vita è così descritta: “Sentirsi ospite ovunque, insediarsi in una casa solo per un tempo, non preoccuparsi del frutteto, godersi il vino piuttosto che attaccarsi alle vigne” (p. 901). Non ho potuto non pensare alla opposta natura di Brandolini, al suo imprescindibile attaccamento proprio alle vigne e al frutteto e a ciò che significano. Chiusa la parentesi.
I gesti quotidiani dei lavori agricoli sono anche terapia per non scivolare nell’abisso, nel lacerante vuoto lasciato dai figli che prendono la loro strada: in Il sentiero accanto al fiume (p. 39) il poeta ammonisce: “Non svegliarti con l’idea dell’abisso: / pianta alberi, potali, raccogli frutti e con l’olio d’oliva / condisci il pane bruscato”. Umili gesti quotidiani, antidoto al precipizio nello sconforto esistenziale.
E sono terapia che massaggia il cuore anche le parole che emergono dal silenzio agreste: bisogna prestare ascolto, perché Dal silenzio arrivano parole (p. 48): “[…] Parole che conoscono / l’odore dell’erba tagliata, del rosmarino, delle rose / piantate decenni fa, da mani amiche, lungo il recinto”.
I legami familiari
Il tema della terra natìa porta con sé quello del legame con le radici familiari, altra costante della poesia brandoliniana. Anche nella raccolta precedente, Il tuo cuore è una grancassa, del 2022, (recentemente tradotto in spagnolo e pubblicato in Spagna e in Messico) sono, per esempio, presenza viva la vigna, il bosco chiamato “Svizzera” (nei Castelli Romani), le rondini, le formiche, il vicolo, le vecchie tegole, e soprattutto il luogo “dove ho piantato / alberi, costruito una casa e per vedervi / felici mi sono preso cura di un giardino” (La vetta inaccessibile, in Il tuo cuore è una grancassa, p. 59). Tema che ricorre identico nella poesia – nella nuova raccolta – Mattoni forgiati con i sogni (p. 65), dove, tuttavia, l’io narrante si rende conto dell’illusione che “una casa semplice ma dai forti pilastri” possa bastare a proteggere la famiglia, conservandola “sottovuoto” e preservandola “da tempeste e invidia”.
E più di tutti i legami, più di quello con la madre, più di quello con zio Lallo, alla cui memoria è dedicato il volume (oltre alla poesia Settembre, di p. 19), più di quello con zia Augusta, che corre a confortare il bambino solo e spaventato (Frasi di conforto, p. 79), più di quello con il sé stesso bambino, che lavora per portare soldi a casa e di notte si rifugia nei libri per sottrarsi all’assordante silenzio familiare (Un bambino, p. 30), un bambino “che rovista nel dolore” (Punti di fuga, p. 53), più di tutti questi legami è tenace e doloroso quello col padre, segnato da irrisolte incomprensioni e da inesausti tentativi di meritarsene l’approvazione.
La casa, la vigna, gli attrezzi, la siepe, il ciliegio, i lavori stagionali, tutto riconduce alla figura paterna. Viene da dire, in luogo di Terra Madre, Terra Padre. In perfetta continuità, ancora una volta, con la raccolta precedente. Esemplari, a tal riguardo, due poesie, una tratta da Il tuo cuore è una grancassa e l’altra da Il fuoco della luna, che sono, direi, i due tempi di un solo poema: Dove sei stato tutto questo tempo? (p. 58), la prima, e Le tue mani sono alberi (p. 14), la seconda, che esplicitamente cita il componimento precedente. In entrambe le poesie la sorpresa dell’incontro col padre, scomparso da tempo, e il sorriso finale che ristabilisce una cara consuetudine.
E, ancora, citerò le parole tratte da Vigna, componimento sempre de Il tuo cuore è una grancassa: “l’assenza del padre non sarà mai un capitolo chiuso”. E, infine, la chiusa di La baracca (p. 33 de Il fuoco della luna): “Un figlio non dimentica nulla, ecco il sentiero che conduce alla vigna, alla baracca dove d’estate il padre dormiva per poi all’alba riprendere il lavoro”.
Incidentalmente, noterò che il nostro autore ha appena (febbraio 2025) tradotto in italiano due raccolte di poesia del messicano José Javier Villarreal, sotto il titolo complessivo Sul campo. Non è certo casuale la scelta di questo poeta, peraltro coetaneo, di cui nell’introduzione Brandolini ricorda le tematiche prevalenti: la “celebrazione dei ricordi, della famiglia”, le “radici che abbracciano alberi e persone, case e strade”, “il coraggio di costruire la propria casa sulle fondamenta della solitudine e senza isolarsi”. Identico è, per esempio, il non interrotto rapporto con i morti: nella poesia I miei nonni, a p. 29, Villarreal dialoga all’alba con il nonno e la nonna; nella poesia Storia I, a p. 39, rivive la figura della madre, vista di nuovo bambina, che cammina “lungo la strada di alberi che tuo padre ha piantato”. Versi come quelli che evocano padre e figlio seduti in silenzio in giardino nella tiepida serata (Un padre si siede con suo figlio, p. 95) potrebbe tranquillamente averli scritti Alessio Brandolini. Un’impressionante somiglianza di universi poetici!
Rimanendo nell’ambito dei complicati tenaci rapporti familiari, in Il fuoco della luna è presente, direi quasi impudicamente esibito, il legame con i figli, in particolare con la figlia. In Pollice sinistro, a p. 11, assistiamo alla umanissima difficoltà paterna di accettare il distacco tumultuoso, la stanza vuota, la consuetudine spezzata del rimboccare le coperte e augurarle la buonanotte. In Fuga precipitosa, a p. 27, ci si presenta l’interruzione brusca del pranzo domenicale e lei che, chiusa la porta, aspetta l’ascensore; e il padre che, a distanza di tempo, matura la consapevolezza, seppur ancor dubbiosa, della necessità per la figlia di quello strappo: “Forse per te era importante farlo”.
Ma ricucire è possibile, tessere di nuovo la tela degli affetti, scambiandosi racconti: così dice il poeta rivolgendosi ai figli: “voi mi direte dei giorni nelle vostre case, / del lavoro. Vi svelerò le ferite del distacco, del cuore / chiuso in una morsa ma contento di vedervi prendere / la vostra via […]” (Il sentiero accanto al fiume, p. 39).
“Avrei dovuto amare di meno e comprendere di più” dice l’autore nella poesia Foto (p. 34), rimpianto che vale verso i figli e per tutti i rapporti: rispettare la libertà dell’altro e mettersi in ascolto delle sue ragioni è il giusto atteggiamento.
Parlarsi
E la comprensione, l’ascolto, ci porta ad un altro tema centrale, e anch’esso costante, nella poetica brandoliniana: il dualismo silenzio-parola.
Il peso del silenzio (“Nessuno ha voglia di parlare”, Un bambino, p. 30), la speranza di romperlo (“in attesa di quel dialogo / che deve nutrire i nostri giorni”, La gatta dallo sguardo scaltro, p. 72), l’irrecuperabilità delle parole non dette (“trascrivo parole che avrei / voluto dire e quelle che avrei desiderato ascoltare”, Davvero tutti uguali?, p. 76; e poi “le parole necessarie / e urgenti, anche quelle non dette e da sempre attese”, Frasi di conforto, p. 79), vanno di pari passo con il rimpianto per le occasioni perdute, le cose non fatte. È salvifico dei rapporti “imparare a dire le parole giuste” (A ogni svolta si apre una voragine, p. 15). Le “frasi ambigue” e “nessuna parola buona” nel disagio dei sismi domestici, mentre zio Lallo era “sempre disponibile […] all’ascolto, al sorriso. / Le tue parole: una fiamma nella mia gelida grotta / e ancora adesso donano conforto, un’umile allegria.” (Settembre, p. 19). Quindi, ci sono parole che fanno male e parole che producono sollievo, e chi è capace di tali parole buone è anche pronto all’ascolto, allo scambio di parole.
E sempre sul tema della necessità di comunicare e della difficoltà di farlo senza ferire e ferirsi, è la poesia, quasi una fiaba, intitolata È qui che dobbiamo stare? (p. 28). Il poeta scende sul fondo del lago, dove, in case di corallo, vivono i pesci, e lì il pesce dal muso azzurro, immagine della mutezza, espressione proverbiale dell’incapacità di parola, si sforza di comunicare, inducendo il poeta a riflettere sul “bisogno di aprire un varco, [sulla] capacità di comprendere e di farsi capire”.
E sulla stessa linea è la poesia Dissodare il silenzio (p. 44), che fin dal titolo indica la via da percorrere: acquisita la consapevolezza che “Troppe cose non si possono dire”, che “Riferire il male separa da tutti”, ci si deve applicare a rompere in profondità la compattezza del silenzio, per prepararlo a ricevere il seme delle “parole giuste”. Ci vuole cura, e coltivare – un terreno, un’amicizia, un amore – vuol dire, appunto, curarlo. Al contempo, l’istinto del poeta è di rifuggire dal Caos delle voci (p. 64), difendendosi dalle frasi che “sono insulti”, dalla bocca che colpisce come una “mitraglia”.
Ma disposti a parlare bisogna essere in due: “Provo lo stesso a parlarti e non ascolti”, dice il poeta, e, nello stesso componimento, consapevole del danno che parole mal dette possono fare (“le parole sono pietre”, avvertiva Carlo Levi), ci ricorda che “le parole non muoiono mai, non cambiano” e “non basta scavare in profondità per interrarle” (Il vento si porta via le tegole, p. 32): ci vuole cautela e delicatezza nell’uso delle parole.
E anche quando si è entrambi disposti a parlare, vincendo timidezza e radicata attitudine all’autodifesa, non è facile riuscirci: così, col fratello si parla del passato, rievocando i capelli neri, le camicie a fiori, la Cinquecento, ma subito sembra di essersi sbilanciati troppo, di essersi avviati verso un’intimità non abituale: “Fissa l’orologio: ci salutiamo non riuscendo a dirci qualcosa in più, pur sapendo che sarebbe importante farlo” (Qualcosa in più, p. 35).
Tuttavia, la consapevolezza della difficoltà del dialogo non porta alla resa ma fortifica la speranza e l’impegno a riprovarci: “Il dialogo procede in salita, così quello che avrei dovuto dirti: ci siamo persi ma potremmo di nuovo incontrarci ed essere meno distanti e distratti” (L’angelo dalla faccia triste, p. 36).
Parlare è necessario per costruire ponti con gli altri; non siamo monadi, e se “nessuno ha voglia di parlare” (Un bambino, p. 30), il poeta, tuttavia, enuncia il suo impegno: “Parlo per non isolarmi” (Il sentiero accanto al fiume, p. 39).
La lingua
Dalla terra e dalla consuetudine con essa proviene anche il lessico asciutto e quotidiano di Brandolini, fatto di termini semplici e immagini essenziali: l’odore del geranio, una mela, la roncola con cui ci si ferisce per soppiantare un altro squarcio, “un tronco abbattuto, tarlato”, “le unghie piene di terra”, “una volpe atterrita”, un cane, una gatta, l’orso, le formiche, “il sentiero che conduce alla vigna”, “le foglie sgualcite cadute dal castagno”. Una sola espressione propriamente tecnica, dialettale: “Stincata l’antica vigna”, cioè, “espiantata” la vigna, nella poesia La purezza che nutre (p. 67). E un’immagine presa a prestito dalle pratiche agricole nella citata poesia Dissodare il silenzio (p. 44): “Dissodiamo / il silenzio: prima o poi verranno le parole / giuste”.
Una lingua che parla di cose umili, quotidiane, comprensibili anche a un bambino (le stelle, le nuvole, il cane, il gatto, le tegole, il frigo, la pioggia, le vecchie fotografie), ma attorno alle quali si costruiscono immagini indelebili, come la pioggia che “inonda i letti e gli armadi” (Lo sguardo buono del cane, p. 40) o la notte, che “è un letto in fiamme: non un’oasi dove riposare” (Fuga precipitosa, p. 27), o “gli armadi [che] fuggono di casa” (Macerie, p. 31) o, ancora, la determinazione di “lubrificare cuore mente ginocchia e collo” (Nei sentieri degli anni, p. 43) o, infine, quadri sorprendenti, come il mare, che “si tuffa / nel Tevere e inonda la città” (Non era colpa mia, p. 74).
Ancora, sinestesie, che rinfrescano immagini logorate: “Nel bosco ronzano / i colori dell’autunno” (Lo sguardo buono del cane, p. 40) oppure “afferrare al volo / il canto misterioso della luce, delle stelle” (Vagano fantasmi, p. 62).
Una predisposizione all’uso dell’ossimoro, a spiazzare il lettore: dal citato titolo della raccolta stessa, Il fuoco della luna, che si precisa come “fuoco gelido della luna” (Parole nella carne, p. 16), al “Il frastuono del non detto” (Negli occhi dell’orso, p. 24). Di passaggio, ricorderò il titolo di un’altra raccolta, altrettanto ossimorico, Tevere in fiamme (2008, Premio Sandro Penna).
È avara di aggettivi la scrittura di Brandolini; il poeta allinea entità concrete, dense, che non necessitano quasi mai di essere ulteriormente connotate. Anche quando sono evocate realtà frequenti nell’immaginario dei poeti (le nuvole, le stelle, l’erba, l’alba, il tramonto, la neve), non si tratta mai di costruire uno scenario, un arredo ma piuttosto la cifra di Brandolini sembra essere quella di proiettare in tali elementi del paesaggio attitudini umane, quasi a cercare nelle manifestazioni naturali quella possibilità di comunicazione e comunione così difficile con gli uomini. È il caso delle stelle, che “bisbigliavano frasi che non capivi” (L’evolversi delle radici, p. 54) o dell’alba che “arriva / macinando incubi” (Fumo d’incendi lontani, p. 55) o ancora del ritrovato “sollievo nelle braccia forti del mare” (Le braccia forti del mare, p. 61).
E a proposito delle stelle, della luna, della notte, contrapposte alla luce diurna, a proposito, dunque, dell’ambivalenza e rovesciabilità dei valori possibili dei due termini in contrasto – il buio e la luce - il poeta ci insegna che la notte, l’insonnia, “le inesauribili stelle” (Ti afferrano i rami degli alberi, p. 41), “il fuoco della luna” fanno chiarezza, acuiscono i sensi, mostrano spiegazioni, scaldano di gioia (Sulla soglia del sonno, p. 13), consentono il “viaggio su altri pianeti“ (Foto, p.34). “Tutto si mostra nell’insonnia e poi l’alba / lo abbatte” (Paesaggio nivale, p. 83). La notte è netta: “la falce lunare taglia in due” e “i raggi lunari aprono sentieri” (Il fossato circolare, p. 50), mentre l’alba, silenziosa e smemorante, distrugge quelle intuizioni e “arriva macinando incubi” (Fumo d’incendi lontani, p. 55). Ma è vero, cioè sperimentato e umano, anche il contrario: “la luce attenua il peso” della sofferenza (Raggiungere il Nepal, p. 58), e “all’alba starai meglio” (Vagano fantasmi, p. 62). Ma è ancor più reale che non c’è giorno senza notte né buio se non in relazione alla luce e i doni di entrambi dobbiamo imparare a riconoscere per avvantaggiarcene: sempre nella poesia di pag. 62, Vagano fantasmi, dice il poeta che all’alba ti affrancherai dal disagio prodotto dai fantasmi notturni ma, intanto, “devi approfittarne, afferrare al volo / il canto misterioso della luce, delle stelle”. Dalla dialettica di luminosità e tenebra può scaturire una scintilla di conoscenza, una pausa all’inquietudine.
Il personale, il civile, l’universale
In estrema sintesi, per nulla semplificatrice, si potrebbe dire che la poesia di Brandolini sia tutta qui. E dire: «tutta qui» non vuol dire «solo questo» ma significa che in un orizzonte volutamente circoscritto l’autore ha distillato la sua visione del nostro passaggio su questa Terra. E «tutta qui» vuol anche esprimere la coerenza di tutti i dieci libri di poesia finora pubblicati, quella coerenza tematica che fa dei dieci libri un solo libro, come anche Enzia Verduchi, traduttrice in spagnolo di una parte di questo libro, ha scritto nell’ottobre del 2024 su una rivista messicana.
Ho molto insistito su quanto la famiglia, i luoghi dell’infanzia, i ricordi, siano i soggetti preponderanti di quest’ultima coesa raccolta di 68 (11+14+20+23) fra poesie e prose poetiche. Ma il mondo di Brandolini non finisce a Monte Compatri, non è circoscritto alla vigna e alla famiglia, per quanto universali e non banalmente privati siano quei temi. Perciò, desidero porre l’accento sulla tensione morale e civile dell’autore, coltivata proprio attraverso il culto della famiglia, della terra e del lavoro. E lo faccio citando almeno tre poesie della raccolta, che si prestano ad una lettura in chiave politica, oltre che personale.
In Il fossato circolare (p. 50), l’autore esprime una constatazione, che può essere letta anche come un’ammissione di colpa generale: “Abbiamo vissuto gli ultimi decenni pensando / che prima o poi avremmo nuotato in un fiume / più limpido”. Mettete chi volete come soggetto di questa prima persona plurale; ci sono dei “noi”, e Brandolini si pone fra loro, che si sono limitati ad aspettare, a sperare in un mondo migliore. Ma si può ancora porre rimedio all’ignavia, come subito aggiunge, esprimendo un proposito, un imperativo civile: “Occorre una visione che trasporti / il più lontano possibile, mostri la sponda dove / ormeggiare, la giusta direzione”.
Anche nella poesia Accenderò fuochi (p. 63), in quello che solo distrattamente possiamo chiamare “il piccolo mondo” di Brandolini, il suo hortus conclusus, fatto di rose, erba, voce paterna, il poeta avanza vacillando, attanagliato dal dubbio: “Aspettare: sì / ma fino a quando? E non sarà troppo tardi?”. Ma, malgrado i lupi che ululano e la paura che agghiaccia, senza eroismo ma con umana e propositiva dignità il poeta conclude: “Accenderò fuochi in una patria senza dolore / con quel poco di rabbia che resta per stare in piedi”.
E ancora la penultima poesia della raccolta, Fare chiarezza (p. 82), che reca la data del febbraio 2024, con riferimento diretto al secondo anniversario della guerra in Ucraina. Tutto quel dolore lontano diventa il proprio: quel bosco remoto è il nostro bosco, quelle case e quelle famiglie sono le nostre case e famiglie. Gli animali si nascondono e anche il cane percepisce la paura e condivide la nostra pena di non saper fermare la ferocia. Una volta di più le immagini consuete (il bosco, gli animali, le case, le famiglie, il cane) sanno prestarsi ad esprimere un dolore universale.
Affinità elettive
Ho accennato ad una somiglianza di accenti con Emily Dickinson, con le debite peculiarità personali. Ma ci sono delle affinità con altri autori, una percorribile lettura intertestuale, che lo stesso poeta ci addita in questa raccolta poetica. I sessantotto componimenti, infatti, sono organizzati in quattro sezioni, ciascuna introdotta da versi di altri poeti, che segnalano amicizie e parentele ideali. La prima sezione, Sulla soglia del sonno, ha in epigrafe versi di Mark Strand, come Brandolini anche editore e traduttore nonché amante dell’America Latina (e dei suoi poeti, che pure ha tradotto). Quella di Strand è una lunga meditazione poetica disillusa, epicurea, sul destino della vita, sul senso del passato, del ricordo, sull’assenza e la morte. La sospensione metafisica delle sue atmosfere (come nei quadri di Edward Hopper, che ha commentato in un libro), resa attraverso i semplici oggetti quotidiani disposti in una trama di apparentemente tranquillizzante ripetitività, in realtà, conduce ad una discesa nel sottosuolo del reale, non diversamente che in Brandolini.
La seconda sezione, costituita da quattordici prose poetiche, s’intitola Le radici delle nuvole, un titolo suggestivo che lega terra e cielo, concreto ed astratto, buio e luce, staticità e movimento, prosaicità e poesia. In epigrafe versi di María Baranda, autrice messicana di cui Brandolini ha tradotto la raccolta Teoria delle bambine per la collana I fili delle Edizioni Fili d’Aquilone. Il tema conduttore della raccolta della Baranda è l’infanzia, avvertita come luogo sconosciuto ma connesso all’oggi, un’infanzia in cui l’aspettativa di gioia si scontra con il disagio, la paura, l’inquietudine, né manca una complessa figura paterna. La parte finale di questa epigrafe è ripresa interamente nella chiusa della poesia Foto (p. 34): “Ciò che resiste al male è stivato su piccole barche di piombo”, con una potente immagine ancora una volta ossimorica. Immagine, questa delle barche di piombo, che torna nella poesia dell’ultima sezione, intitolata Nulla è più insolito dell’amore (p. 69), dedicata alla moglie Laura. (Ma altrove – nella poesia Il fossato circolare (p. 50) – troviamo anche rassicuranti “barche di carta cariche di parole”).
La terza sezione reca in epigrafe due versi di Thomas Stearns Eliot, tratti dalla raccolta Four Quartets, scritta fra il 1936 e il 1942, cioè successivamente alla conversione al cristianesimo e connotata da un’apertura alla speranza, nel superamento del pessimismo che caratterizza opere precedenti come The Waste Land. I due versi scelti indicano nell’umiltà la sola saggezza alla nostra portata (“the wisdom of humility”), onesta e modesta consapevolezza che Brandolini fa propria, scrivendo, nella chiusa di Posso farlo anch’io (p. 49), “Si vuol bene come si può, / ti dici, in modo imperfetto, ma con tutte le proprie forze”. Un’umiltà che, pur con la coscienza della limitatezza umana, è determinazione all’impegno, con la stessa costanza e serietà impiegata nel potare il ciliegio o dissodare il terreno: attività semplici, discrete, pazienti e perciò stesso portatrici di frutti.
La quarta ed ultima sezione, Nella terra di nessuno, ha in epigrafe versi tratti dall’Ovidio dei Tristia, i distici elegiaci dell’esilio nel Ponto, un ininterrotto lamento per quel severo confino, che trova nella poesia l’unica consolazione. La prima poesia della sezione, Le braccia forti del mare (p. 61), presenta un Brandolini che vuole identificarsi con il forse incolpevole poeta latino e che subito si prende in giro per “il vizio di veder[si] in altre storie”. Ed è un omaggio a Ovidio l’ultimo componimento della sezione e del libro intero, intitolato Paesaggio nivale (p. 83), ove si ricordano le oscure motivazioni dell’esilio, l’irrecuperabilità dell’antica condizione, la consapevolezza che toccherà morire in terra straniera. Eppure, ci dice il nostro autore, a tale prostrazione il poeta di Sulmona riesce ad opporre la piccola gioia donata da un paesaggio innevato e dalla possibilità di fermare quell’immagine con parole di poesia. Anche per Ovidio deve essere vero che “scrivere / è un respiro lento che dona linfa al cuore” (L’ultimo tentativo, p. 47).
Poi ci sono le dediche delle singole poesie. Naturalmente, ai familiari. Oltre al citato zio Lallo, la dedica al padre (Le tue mani sono alberi, p. 14), alla zia Augusta (Frasi di conforto, p. 79), alla moglie Laura (Nulla è più insolito dell’amore, p. 69), ai figli Simone e Flavia (Il sentiero accanto al fiume, p. 39, ma a Flavia anche In fretta ci si lascia tutto alle spalle, p. 81), e pure alla gatta Munin (La gatta dallo sguardo scaltro, p. 82), tutti legati da una sola catena di affetti e ricordi. E voglio menzionare anche la dedica della poesia Raggiungere il Nepal (p. 58) al poeta venezuelano Ígor Barreto, di cui Brandolini ha tradotto e pubblicato nel 2021 l’antologia Ultimo giorno di viaggio, in cui si rincorrono il richiamo pur non nostalgico al passato, il ponte fra vita e morte, l’attenzione alle umili esistenze di lavoratori, tutti argomenti anche brandoliniani; così come il Nepal del titolo rimanda alla raccolta Annapurna di Barreto, ove il reale si fonde con il sogno e il quotidiano con la grandiosità evocata dalla cima himalayana.
E, se quello verso l’Annapurna è un viaggio virtuale, il modo migliore di viaggiare è sentire, come recita Álvaro de Campos in epigrafe alla poesia Sentire in tutti i modi (p. 66), nella quale il senso di oppressione derivante in gioventù per Brandolini dai ristretti ambiti familiari e dai limitati orizzonti del paese trova sollievo gioioso nell’ascolto, ancora una volta, delle parole di zio Lallo. Di Álvaro de Campos, l’eteronimo di Fernando Pessoa che più si è guadagnato una vita propria rispetto al suo creatore, Brandolini fa propria la faticosa attitudine a sentire tutto l’universo dentro di sé, ad accogliere lo straripamento del tutto, “fino a lacerarsi” in un’infinità di percezioni.
Un’ultima parentela di elezione che mi piace ricordare quella con la fotografa statunitense Vivian Maier, il cui ritratto affettuoso è nella poesia Nel grande specchio (p. 57), nella terza sezione, quella dedicata alla saggezza dell’umiltà. Ho conosciuto l’opera di Vivian Maier attraverso la ricca mostra presentata nella primavera del 2017 presso il Museo di Roma in Trastevere, che forse ha visitato anche il nostro poeta. Artista di street photography, scoperta tardivamente (faceva la bambinaia), credo abbia colpito Brandolini per la capacità di osservazione, cioè non solo di guardare ma di vedere veramente. Chi e cosa? I vecchi polacchi di Chicago, i bambini afroamericani, i mendicanti, una venditrice di ciambelle per strada, operai, cantieri edili, cioè tutto quella invisibile quotidianità minima che cela un nocciolo di struggente e profonda infinità. E non è un caso, credo, che la Maier sia stata accostata alla Dickinson: tutto torna, dunque, anche con riferimento al nostro Brandolini, che condivide con entrambe la capacità, come già detto sopra, di trovare significati assoluti nell’apparente banalità di una lumaca che striscia, una gatta che scappa, una bruschetta con l’olio, capace anch’egli di mettere “l’occhio nelle cose”. E questa poesia, che descrive con poche pennellate l’aspetto e l’atteggiamento della Maier, per poi richiamare i soggetti dei suoi scatti, si chiude evocando un’altra attitudine della schiva fotografa statunitense, cioè quella di fotografarsi negli specchi e nelle vetrine, cioè di farsi l’autoritratto, inserendo sé stessa, riflessa, in quel contesto di umanità umile e dimessa: “Alla fine sorridi / fotografandoti nel grande specchio caricato sul camion”, che è, poi, l’ultima foto del catalogo della mostra che ho ricordato sopra.
Per concludere
La tensione che pervade la raccolta, fra irrealizzabili desideri retroattivi di risistemare il passato e angosce pietrificanti nel presente, non si può risolvere, non c’è tempo né modo per recuperare. Ma qualcosa rimane da fare, per non cedere al baratro, qualcosa di difficile ma umano, molto umano: “avanzare adagio sulla corda sospesa / nel vuoto” (La corda sospesa nel vuoto, p. 12), come colui che “mette un piede dietro / l’altro e avanza pur avendo la sensazione / di restare immobile (Sulla soglia del sonno, p. 13).
Ed è proprio nella poesia che Brandolini, come dicevamo dell’ultimo Ovidio, trova la sua medicina, la strada personale per non finire a sbattere contro un muro o essere sopraffatto dalle ombre del passato. Come ricordato poco sopra, “Scrivere / è un respiro lento che dona linfa al cuore, a mani / e piedi” (L’ultimo tentativo, p. 47). La scrittura rasserena ed è curativa e rigenerante per lo spirito e finanche per il corpo. Così, alla fine dello stesso componimento:
È l’istante di accendersi dentro e sorridere
agli angoli più cupi del passato, farli saltare in aria.
Il fuoco della luna di Alessio Brandolini è stato presentato a Roma il 27 marzo 2025 presso la sede dell’associazione di promozione sociale TRAleVOLTE, con l’autore accompagnato da Marina Marotta e Monica Elisei.
 Alessio Brandolini (1958) Alessio Brandolini (1958)
vive a Roma dove si è laureato in Lettere. Ha pubblicato i libri di poesia: L’alba a piazza Navona (1992, Premio Montale Inedito), Divisori orientali (2002, Premio Alfonso Gatto Opera Prima), Poesie della terra (2004), Il male inconsapevole (2005), Mappe colombiane (2007; tradotto in spagnolo: Mapas colombianos, Colombia 2015), Tevere in fiamme (2008, Premio Sandro Penna), Il fiume nel mare (2010, Finalista Premio Camaiore), Nello sguardo del lupo (2014; tradotto in spagnolo: En la mirada del lobo, Messico 2018), Il volto e il viaggio (2017, con disegni di Stefano Cardinali), Il tuo cuore è una grancassa (2022; tradotto in spagnolo: Tu corazón es un bombo, Spagna-Messico 2025) e Il fuoco della luna (2024).
Sono uscite le antologie: Il futuro è un campo incolto (2016) e Città in miniatura (2021; tradotto in inglese: Miniature Cities, Stati Uniti, 2023 e in spagnolo: Ciudad en miniatura, Colombia, 2024). Antologie della sua opera sono state pubblicate in Costa Rica, Colombia, Argentina e Romania.
Nel 2013 ha pubblicato il libro di racconti Un bosco nel muro. Traduce dallo spagnolo e dal 2006 coordina «Fili d’aquilone», rivista web di «immagini, idee e Poesia». Nel 2011 ha fondato la casa editrice Edizioni Fili d’Aquilone.
marina_marotta@yahoo.it
|