I giovani narratori rivelano capacità di sondare gli abissi spesso assenti dai dorati – e non duraturi – universi epocali, storico-narrativi, popolar-politici dell’ufficialità dettata dai premi, dai riconoscimenti che contano, a loro volta apparizioni, medialità, sottile ma visibile linea fatta di sostegni editoriali, soprattutto, e amicizie, e politica. L’eterno ritorno, di cui tra l’altro, si parla nel romanzo qui recensito. E dopo tante apparenti rivoluzioni, politiche e di costume, per ritrovarci esattamente come ieri e ieri l’altro. Sono pochi quelli che hanno il coraggio di non curare le modalità d’approccio al sistema, scegliendo di respirare – e scrivere – in perfetta solitudine, fuori dai dettami ma dentro, nelle radici elementari del sé narrante.  Come nel caso di Giuda è stato tradito di una assai giovane esordiente, Claudia Luzzi, che rivela però il coraggio di andare molto a fondo con la ricerca di ragioni. Già il titolo lascia intuire altro: la solitudine dell’escluso, del non desiderato, del carnefice-vittima, il ragazzo che ha causato la morte della mamma nel parto e a cui è stato affibbiato un nome che in occidente pesa come un macigno, quel nomen-omen che da solo costruisce (e demolisce) una vita, anche a non volerlo. La giovinezza porta con sé qualche asprezza e qualche ingenuità (e l’affidarsi ad alcuni luoghi comuni, ad esempio l’espediente abusato del testo ritrovato e pubblicato), come quella del Giuda evangelico “costretto” a tradire Gesù nel disegno della salvezza, ma rimane un romanzo-sonda che permette l’ingresso dentro il magma di una coscienza dolente, con la capacità di narrare i fantasmi al di là di compiacimenti estetizzanti e di false idealità “civili”. La predestinazione, i dubbi, le domande inquiete su che cos’è e chi è Dio, la vita, l’altro e l’oltre sono affidate ai rumori della città, gli interni del bar presso cui lavora il protagonista, gli uffici, gli studi degli psicologi, i cimiteri, le stanze del quotidiano. Fanno parte del discorso, si inseriscono nella narrazione come dolenti scenari di alienazione, labirinti in cui sono nascosti il pensiero e il senso, ma anche il nemico. Non protagonisti come nei ’50 dell’école du regard, ma forse più simili ad alcuni interni hopperiani, suggeritori di inquietudine non solo per una situazione individuale, ma per il ruolo dell’uomo nella pòlis. Diari di pochi giorni e narrazioni nella narrazione, senza punti di snodo e di chiarificazione, se non per il cambio di caratteri grafici, fanno di questa storia un continuum non solo narrativo, ma attento al fondo dello spirito, fatto di riflessioni che richiamano tra gli altri Schopenhauer e Nietzsche, senza per questo esserne tributarie, di considerazioni sui limiti di una scienza che è contrabbandata come risposta di tutto: Come nel caso di Giuda è stato tradito di una assai giovane esordiente, Claudia Luzzi, che rivela però il coraggio di andare molto a fondo con la ricerca di ragioni. Già il titolo lascia intuire altro: la solitudine dell’escluso, del non desiderato, del carnefice-vittima, il ragazzo che ha causato la morte della mamma nel parto e a cui è stato affibbiato un nome che in occidente pesa come un macigno, quel nomen-omen che da solo costruisce (e demolisce) una vita, anche a non volerlo. La giovinezza porta con sé qualche asprezza e qualche ingenuità (e l’affidarsi ad alcuni luoghi comuni, ad esempio l’espediente abusato del testo ritrovato e pubblicato), come quella del Giuda evangelico “costretto” a tradire Gesù nel disegno della salvezza, ma rimane un romanzo-sonda che permette l’ingresso dentro il magma di una coscienza dolente, con la capacità di narrare i fantasmi al di là di compiacimenti estetizzanti e di false idealità “civili”. La predestinazione, i dubbi, le domande inquiete su che cos’è e chi è Dio, la vita, l’altro e l’oltre sono affidate ai rumori della città, gli interni del bar presso cui lavora il protagonista, gli uffici, gli studi degli psicologi, i cimiteri, le stanze del quotidiano. Fanno parte del discorso, si inseriscono nella narrazione come dolenti scenari di alienazione, labirinti in cui sono nascosti il pensiero e il senso, ma anche il nemico. Non protagonisti come nei ’50 dell’école du regard, ma forse più simili ad alcuni interni hopperiani, suggeritori di inquietudine non solo per una situazione individuale, ma per il ruolo dell’uomo nella pòlis. Diari di pochi giorni e narrazioni nella narrazione, senza punti di snodo e di chiarificazione, se non per il cambio di caratteri grafici, fanno di questa storia un continuum non solo narrativo, ma attento al fondo dello spirito, fatto di riflessioni che richiamano tra gli altri Schopenhauer e Nietzsche, senza per questo esserne tributarie, di considerazioni sui limiti di una scienza che è contrabbandata come risposta di tutto:
L’uomo nella sua presunzione però cerca di dare un perché a tutto: la mela cade dall’albero perché è attratta dalla forza di gravità, la cui accelerazione è di 9,8 metri al secondo quadrato … nei sogni degli uomini! La mela cade dall’albero perché è così che funziona il mondo. Così va l’universo, allora dovremmo dire: l’universo va per conto suo, poi noi, volendo avere l’illusione di capirlo gli abbiamo dato tanti nomi, lettere e numeri (…).
Come si vede, coraggio e indifferenza a regole e bon ton intellettual-borghese, nel senso che non ci sono allineamenti con la vulgata scientista e razionalista a tutti i costi, ma se mai un ritorno alle radici di una parte della letteratura, che non dà per scontato che la conoscenza sia quella che ci propone la scienza, singolarmente prossima all’indeterminazione di Heisenberg, che al di là del contesto prettamente scientifico ha posto nel Novecento – e continua a porre ancora oggi – la domanda che cos’è davvero la realtà. E, merito di questa narrazione, l’accostamento al Macbeth proposto improvvisamente, “life’s but a walking shadow, a poor player/ that struts and frets his hour upon the stage/ and then his heard no more: it is a tale/ told by an idiot, full of sound and fury,/ signifying nothing” non è peregrina. L’idiota che racconta una storia piena di rumore e furia, che ha tanto insegnato alla letteratura dei secoli a venire, non solo a Dostoevskij e Faulkner, ha evidentemente ancora molto da dire.
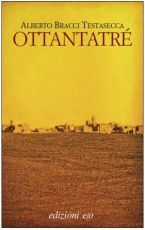 Ottantatré di Alberto Bracci Testasecca, che è alla sua terza opera narrativa, è apparentemente un romanzo storico, ma con l’espediente della “schidionata” che infilza una lunga, e essenziale per la nostra storia recente, linea di avvenimenti attraverso la vita intera del personaggio Giustino. In realtà questo fedele – cronologicamente parlando – itinerario tra la storia e la cronaca rappresenta l’accettazione del reale attraverso, semplicemente, la sua ostensione narrativa. Tutto quello che accade potrebbe accadere ad uno di noi, come la preoccupazione di padri se i figli, crescendo, mostrano eccessiva inclinazione alle utopie, mentre il tempo passa e il lavoro si allontana (magari per poi lamentarsi del mondo cinico e baro e per di più schiavo del materialismo e delle banche). Come nell’esempio della comune in cui va a vivere il figlio di Giustino: si torna alla natura, si mungono le vacche, ma, nei pensieri paterni, ci si allontana dai modelli di produzione dell’ultimo Novecento in rapida accelerazione: Ottantatré di Alberto Bracci Testasecca, che è alla sua terza opera narrativa, è apparentemente un romanzo storico, ma con l’espediente della “schidionata” che infilza una lunga, e essenziale per la nostra storia recente, linea di avvenimenti attraverso la vita intera del personaggio Giustino. In realtà questo fedele – cronologicamente parlando – itinerario tra la storia e la cronaca rappresenta l’accettazione del reale attraverso, semplicemente, la sua ostensione narrativa. Tutto quello che accade potrebbe accadere ad uno di noi, come la preoccupazione di padri se i figli, crescendo, mostrano eccessiva inclinazione alle utopie, mentre il tempo passa e il lavoro si allontana (magari per poi lamentarsi del mondo cinico e baro e per di più schiavo del materialismo e delle banche). Come nell’esempio della comune in cui va a vivere il figlio di Giustino: si torna alla natura, si mungono le vacche, ma, nei pensieri paterni, ci si allontana dai modelli di produzione dell’ultimo Novecento in rapida accelerazione:
Ha imparato a mungere le mucche e mietere il grano, e a quanto ho capito passa ore seduto davanti a una candela accesa, in meditazione. Esperienze di vita, d’accordo, ma comincio a chiedermi come possano essergli utili in un mondo sempre più competitivo e inflazionato, dove il denaro dimezza ogni anno il proprio valore, con il pane che costa cinquecento lire al chilo (siamo nel 1977, ndr) e la benzina che ha superato le trecentocinquanta lire al litro.
Come si vede, siamo di fronte ad una prospettiva tutta interna al racconto, il narratore è parte della storia, la vive dall’interno, ma la mìmesis che questo procedimento propone presuppone un passo indietro, una ulteriore scelta, che è quella di sfuggire alle tentazioni di un giudizio storico immediatamente nello spazio deputato della scrittura e di lasciare una sostanziale libertà al lettore. In realtà la prospettiva narrativa, enunciata dal personaggio chiave, lo si intuisce alla fine, è assunta da un narratore super-personale, che sovrintende alle strategie profonde del testo, che accompagna con apparente imparzialità la nascita, gli eventi bellici, il lavoro, la ricostruzione e poi l’immersione nella cappa di piombo del terrorismo, gli amori e la lenta descensio nella vecchiaia, non esentata per questo dall’apparizione della sirena per eccellenza, quell’amore che nelle sue innumerevoli facce non conosce sosta perché motore dell’universo. Quello che sembra a tutta prima un romanzo storicamente incentrato su un solo personaggio, in realtà è un racconto corale, perché qui, alla fine, si ha l’idea che l’autore sia riuscito a far parlare una generazione, a sua volta, senza soluzione di continuità, indissolubilmente legata alle precedenti e a quelle che verranno. La semplicità mimetica del linguaggio è qui notevole, perché il significato profondo vi emerge lo stesso, dettato dall’evidenza dei fatti più che dalle parole. Impresa difficile, perché la tentazione poteva essere quella di aggiungere materiali linguistici, disporli in modo tale da spiegare o affascinare. Qui la lingua non ha questa funzione, resta “neutrale”, tesa a manifestare gli eventi. Quando la narrazione si focalizza sui pensieri del protagonista, si piega al medesimo ritmo delle denotazioni che dicono il fuori. Non vi sono cambi di registri, l’assemblaggio delle voci è di natura polifonica, risponde ad una strategia unitaria, armonizzata e compiuta nel suo essere. Sono due fondamentalmente i registri che si alternano in Ottantatré: uno è quello denotativo, andante, che ha il compito di presentare personaggi e azioni, disporli in un panorama in cui regna la tranquilla enunciazione degli eventi. L’altro è un pedale più connotativo, basato su un umorismo di fondo, una nota a piè di pagina che suggerisce l’accettazione e la demitizzazione dell’esistente attraverso l’ironia, l’abbassamento e il rovesciamento. Ma non siamo di fronte ad un romanzo di denuncia o ad un esercizio sulla impraticabilità dell’esistente, anzi. Si ha la sensazione che il messaggio sia l’accettazione delle increspature di superficie del mare profondo dell’esistenza, che, ce lo ha insegnato la scienza novecentesca, non accetta spiegazioni scientiste o spiegazioni tout-court. Il destino ci accomuna tutti, anche quando il tempo che passa ci manda inquietanti segnali:
Sento gli occhi che mi si riempiono di lacrime. Mi alzo ed esco sul balcone, ma neanche le stelle sono più le stesse, come a Sainte-Maxime. La nuova prosperità economica ha portato con sé una strana paura del buio, ci sono lampioni e riflettori dappertutto, non c’è più quell’oscurità intima e un po’ paurosa che da giovane mi faceva sognare, il cielo è sbiadito. Mi hanno rubato la notte.
Una vena di stoicismo, di accettazione sorridente anche se un po’ ansiosa, della vita come immutabile gioco, troppo oltre per essere svelato, è la chiave che apre le profondità nascoste dietro questa apparentemente leggera storia di una generazione.
Claudia Luzzi, Giuda è stato tradito, Europa Edizioni, 2013, pagg. 118, 13,90 euro;
Alberto Bracci Testasecca, Ottantatré, edizioni e/o, 2013, pagg. 200, 16 euro.
testi.marco@alice.it
|