Juana, riprendi.
Che cosa?
Riprendi a studiare.
Iniziamo ora
potremmo preparare
una materia.
La frequentazione delle cose, il loro enunciarsi nell’accadere, il senso del limite del canto – dopo i rovesci della storia dell’uomo – sembra essere il luogo della poesia in questo L’occhio di Celan dell’argentina Susana Szwarc (Edizioni Fili d’Aquilone, 2016). Il senso dell’accadere è inscindibile da quello del pensiero, non vi è una priorità né un legame razionale o filosofico, nonostante i riferimenti a Spinoza e a Celan. E ad altri. Se ne possono cogliere i frammenti che manifestano quell’accadere, ma non il suo senso. La giovane, l’altra, il caffè, lo scambio di parole apparentemente senza senso, ma che in realtà denunciano il precipitare di pezzi di realtà nell’attimo in cui tutto accade, dalla caccia alle balene alla possibilità che lo studio porti altrove. Che è una bella innocente metafora del sottile filo che dovrebbe, per alcuni, separare la realtà, nel caso la si potesse individuare con umane parole, dalla teoria, dal mondo dell’intelletto e della speculazione. Qui tutto è stato detto ma nel contempo sembra che nulla sia davvero dicibile. La tentazione di attribuire ogni cosa all’accadere della storia – l’autrice è nata in Argentina da una famiglia di ebrei polacchi –, al trauma epocale dell’olocausto, alla presenza ostensiva dell’atto finale celaniano è limitativa. Nulla è uguale a prima e qui non c’è l’immobilismo della resa ai fantasmi del non senso. Motivi latamente biblici ed alti, come quello della lampada che guida nella ricerca di senso – e nella notte senza stelle – precipitano nel sorriso che illumina la complicità dell’attimo, del contatto, dell’altro:
Se piove anche questa notte, sarò persa.
Vorrò che mi dica di nuovo domani.
Girerò di più per la casa. La tua lampada sosterrà
la mia testa e io riderò nell’oscurità.
Basterebbe questa citazione per intuire che la poesia della Szwarc è allergica alle catalogazioni ma soprattutto alle conclusioni. Versi in fieri, che tendono ad un dinamico dipanarsi nelle pieghe delle cose. Come nota Brandolini nella sua prefazione, si assiste qui alla rottura dei luoghi comuni, alla assoluta gratuità e fedeltà di un verso che cerca di riflettere il reale, fatto di cose, comprese quelle non “materiali” e che accadono lo stesso. Sembra quasi che la poetessa stia indicando la possibilità che si possano rovesciare antiche certezze, come quella della inutilità delle parole e soprattutto della poesia, che anzi, essa sola, possa aiutare a riprendere in mano il cammino attraverso le cose. Ma, sembra dire la Szwarc, con leggerezza, con uno spirito nuovo, non più esclusivamente adagiato, come sarebbe logico aspettarsi dalla sua storia familiare, sul dolore del ricordo che rende impossibile qualsiasi elusione. Appare qui una sorta di circolare via d’uscita, fatta di accettazione nonostante tutto, di resa alle cose e al loro suono nelle parole, anche quelle apparentemente meno paludate e seriose, anzi, proprio quelle: l’ingresso in un bar, il tentativo di studiare per fare esami, la ripresa dei motivi sacri in ambito prosaico, l’accadere, indifferente come un gatto, della quotidianità, a volte sonnolenta, a volte inquietante. L’elementare affermazione della voce – poetica o no – nello spazio e nel tempo – “basta portare quelle frasi/ alla bocca”, dice il naturale radicalmente annidato in noi – è la cifra più intrigante di questa voce che tenta di uscire dalle catene imposte dalla violenza della storia e di modelli ambigui, sospesi come sono tra memoria e thanatos, per fondare quello che Mallarmé avrebbe chiamato “Le vierge, le vivace et le bel aujourd’hui” in una ripresa che ha dell’impressionante per vicinanza empatica e storica, quella della Micol del Giardino dei Finzi-Contini.
Susana Szwarc, L’occhio di Celan, a cura di Alessio Brandolini, Edizioni Fili d’Aquilone, 2016, pagg. 104, euro 15.
CINQUE POESIE DI SUSANA SZWARC
da L'occhio di Celan
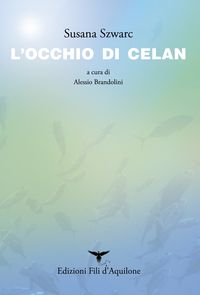
|
NEBULIZZAZIONI
“Ci apriamo alla cosa e la cosa si apre
per noi”
assicura la superbia occidentale
che calpesta i talloni
della mia stessa superbia.
Sbarrata sarebbe stata se gli alberi
avessero scoperto il bosco
ma la sbarra si spezza
ed io, amiche, cado sempre a pezzi
proprio
negli interstizi dalla storia
sempre estranea.
Ecco, dico una certa etica
cioè, la mia mancanza di principi
cioè, nessun principio
o “la libertà che fonda la verità
e che nel contempo – annunciano – la interra”.
Quello che l’essere pattuisce
si scrive solo in altri corpi
mentre (il cappello è di Beckett)
ugualmente convocata
io mi divido.
PASSEGGERI
Ci si stancò, diciamo, al camminare.
Pari, dispari, distesi
osserviamo le stelle.
Mi avvicino alla tua scapola:
c’è un posto per riposare, dico
e saltiamo sul vagone.
Quei ragazzi del treno giocano: ballano
adesso sul mio sterno
e ridiamo del pane nelle borse.
Residui, ciò che siamo questa notte,
questo giorno. E ci sentiamo contenti.
Le foglie dell’albero, gialle, entrano
dalle finestre, adornano
i corpi.
Di notte, di giorno,
i passeri sui rami saltellano.
Uno vola sulla foglia che sta cadendo.
*
Si apre la mia bocca per chiedere caffè ma dice:
studi? La ragazza, diciassettenne, non
ho tempo, e ride.
Non posso chiudere la mia bocca che non
tace: guadagni parecchio?, hai campi
di soia? Ride ancor più e null’altro.
Deliberano i miei pensieri: forse
la soia scaccia il libro? Immagini
di diboscamenti assaltano la mia vista.
La tazza sul tavolo e il giornale
dove leggo: in Arkansas, la vigilia
di Natale, milioni di merli
dalle ali rosse, sono morti.
Connessa al netbook, ti scrivo:
non erano le balene che la Yourcenar difendeva
né i tredici modi di contemplare il merlo.
Haiti, Haiti devastata.
Qui, durante la siesta, le nuvole non coprono
il caldo. Presto a scuola ci sarà
acqua potabile?
Per questa volta
non mi contraddico.
Juana, riprendi.
Che cosa?
Riprendi a studiare.
Iniziamo ora
potremmo preparare
una materia.
*
Ha riempito tre fogli, li ha numerati: uno due tre
e ’sta volta il vento se n’è andato. Ho piegato in quattro
i fogli. Mi dici in quale libro li hai riposti?
Se piove anche questa notte, sarò persa.
Vorrò che mi dica di nuovo domani.
Girerò di più per la casa. La tua lampada sosterrà
la mia testa e io riderò nell’oscurità.
Dove diceva di quella mano sulla bocca, dell’arco
e il sedile portato in piazza? Dove la benedizione
di colui che finiva col perdersi?
GUARDO COME TI OSSERVO
Guardo come ti osservo.
Mi sento ascoltarti
in forma eccezionale (lontano
e diverso il disegno della mappa)
Ricordi?, Molloy colpiva la testa
della madre: un luogo comune se il fatto
si verifica nei limiti dello spazio
conosciuto: lacasa, lalingua, lapatria.
Da prima dei tempi, sempre,
figli-figlie, rompono vasi,
pietre, nocche
sulle teste delle madri
per una giusta ragione.
Sedotti
dalla crudeltà del mondo,
allontanati dai seni generosi,
i corpi feriti da cifre,
bisturi, pavoni, guerre,
notti, giorni, non c’è
alcun modo di sopportare.
Solo si aggiunge quel colpo attraverso
le brusche generazioni.
(Dà una funzione la crepa,
perfetta. Toc-toc).
|
Traduzione dallo spagnolo di Alessio Brandolini
 Susana Szwarc Susana Szwarc
è nata a Quitilipi (Argentina) nel 1954 e vive a Buenos Aires. Ha pubblicato sia libri di poesia che di narrativa, tra i quali: El artista del sueño y otros cuentos (1981); En lo separado, (poesia, 1988); Trenzas (romanzo, 1991); Bailen las estepas (poesia, 1999); Bárbara dice (poesia, 2004 e 2005; tradotto in francese e pubblicato in Francia nel 2013); El azar cruje (racconti, 2006); Una felicidad liviana, cuentos (2007); Aves de Paso (poesia, 2009) e El ojo de Celan (poesia, 2014). È del 2014 l’antologia La mesa roja.
Ha pubblicato anche libri per l’infanzia, tra i quali: Había una vez una gota (1996); Había una vez un circo (1996); Salirse del camino y otros cuentos (1997) e Tres gatos locos (2010). Ha scritto commedie (rappresentate in vari teatri argentini) e un suo racconto è stato adattato, dal compositore Cristian Varela, per una rappresentazione operistica. Ha curato antologie, tra le quali Cuentos Ecológicos (1996) e Mujeres 3, Visiones en el siglo (1998).
Suoi testi (poetici e narrativi) sono stati inseriti in lavori collettivi, sia in Argentina che all’estero, e tradotti in diverse lingue. Dal 1985 coordina seminari di lettura e laboratori poetici. Ha ricevuto numerosi premi letterari, sia per la poesia che per la prosa.
Nel 2016 è stato pubblicata in Italia la raccolta poetica L’occhio di Celan (Edizioni Fili d’aquilone, a cura di Alessio Brandolini).
testi.marco@alice.it
|